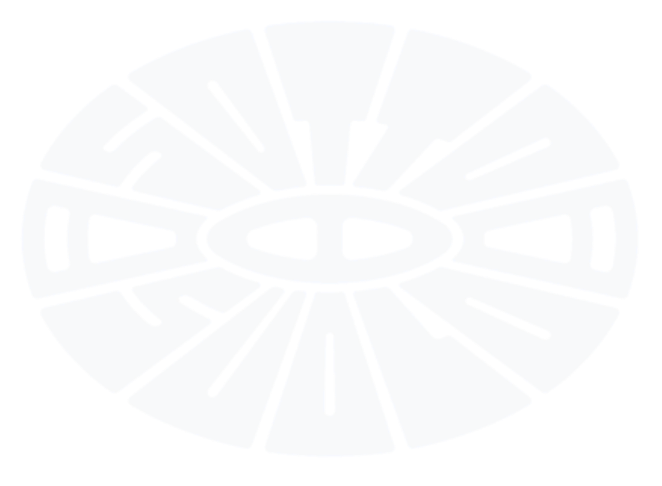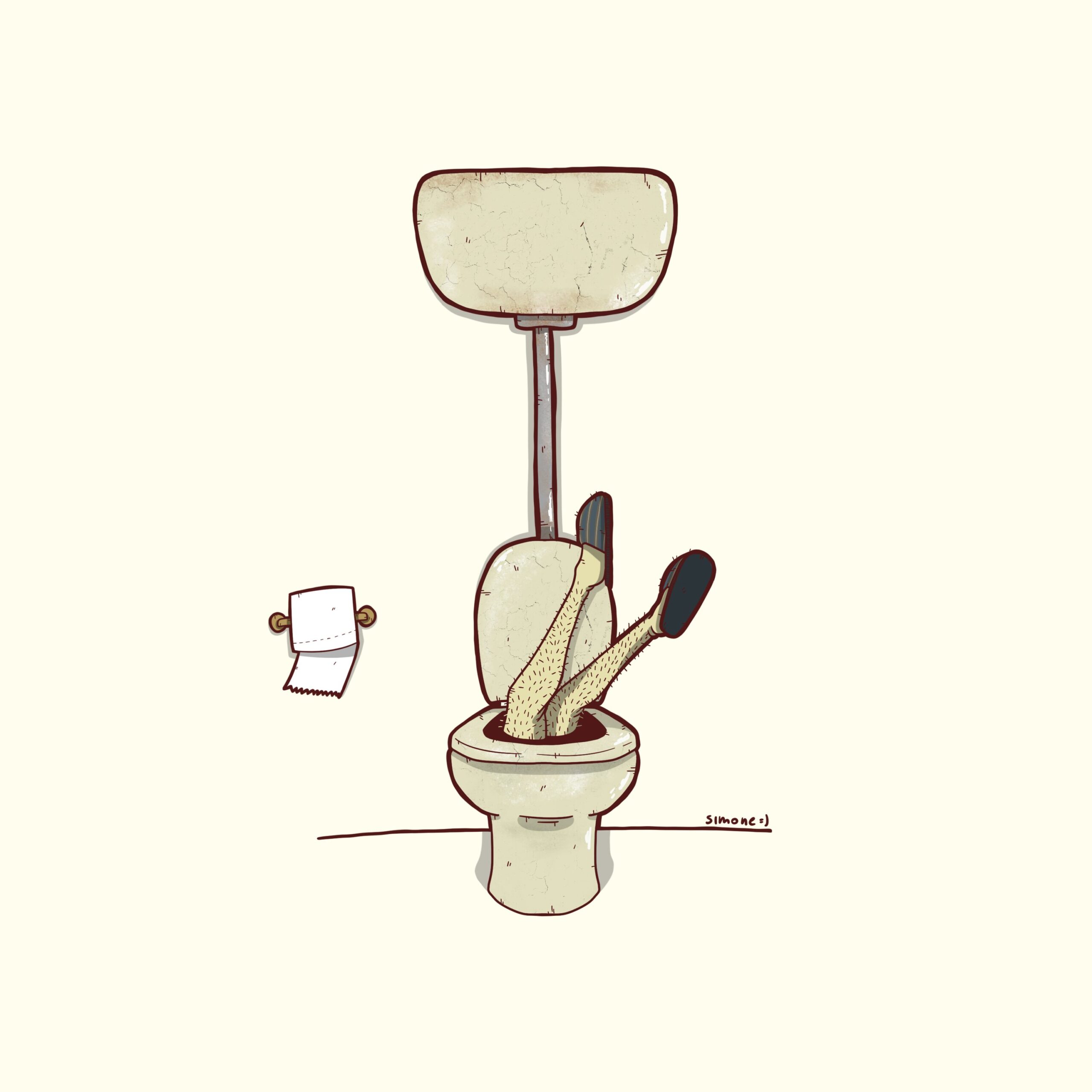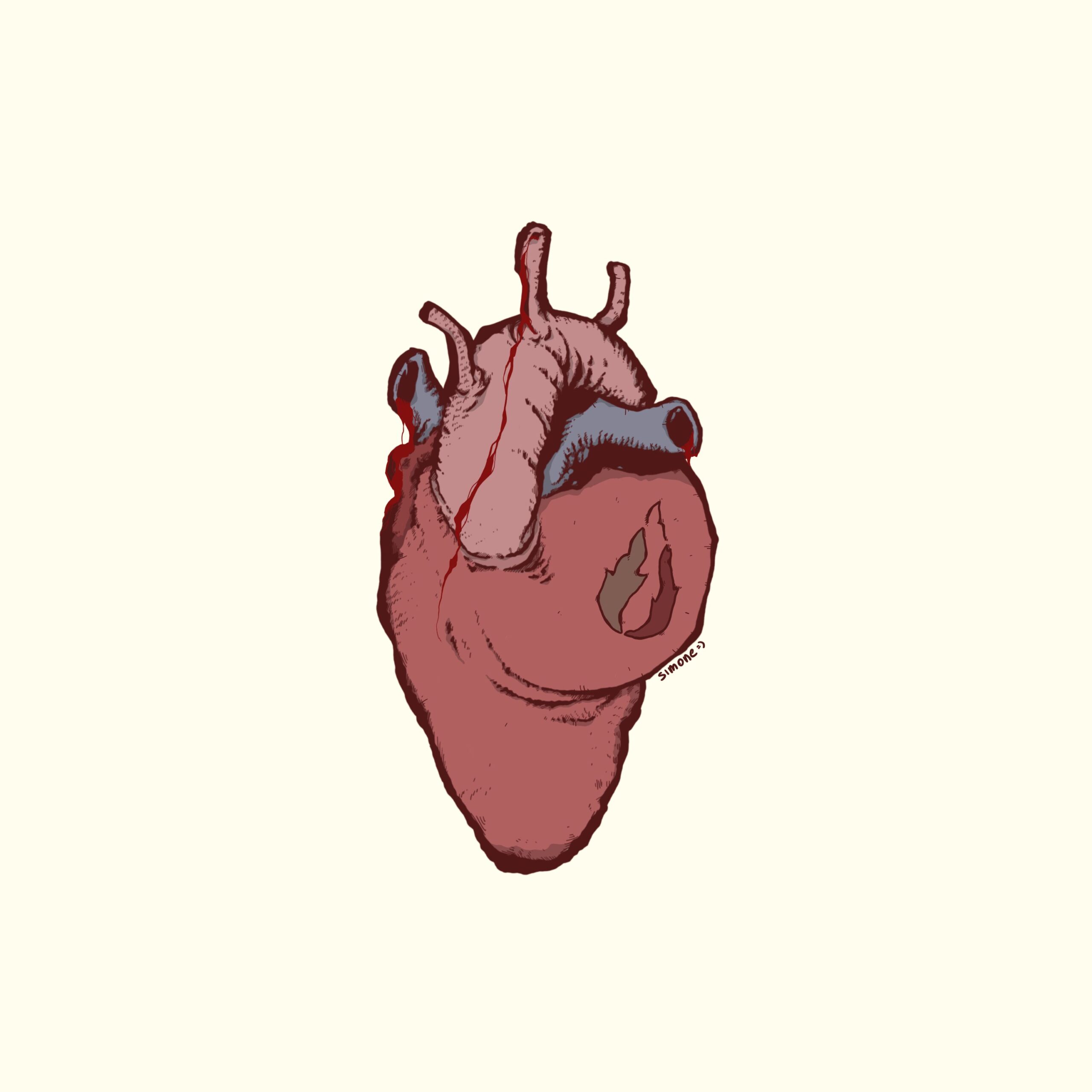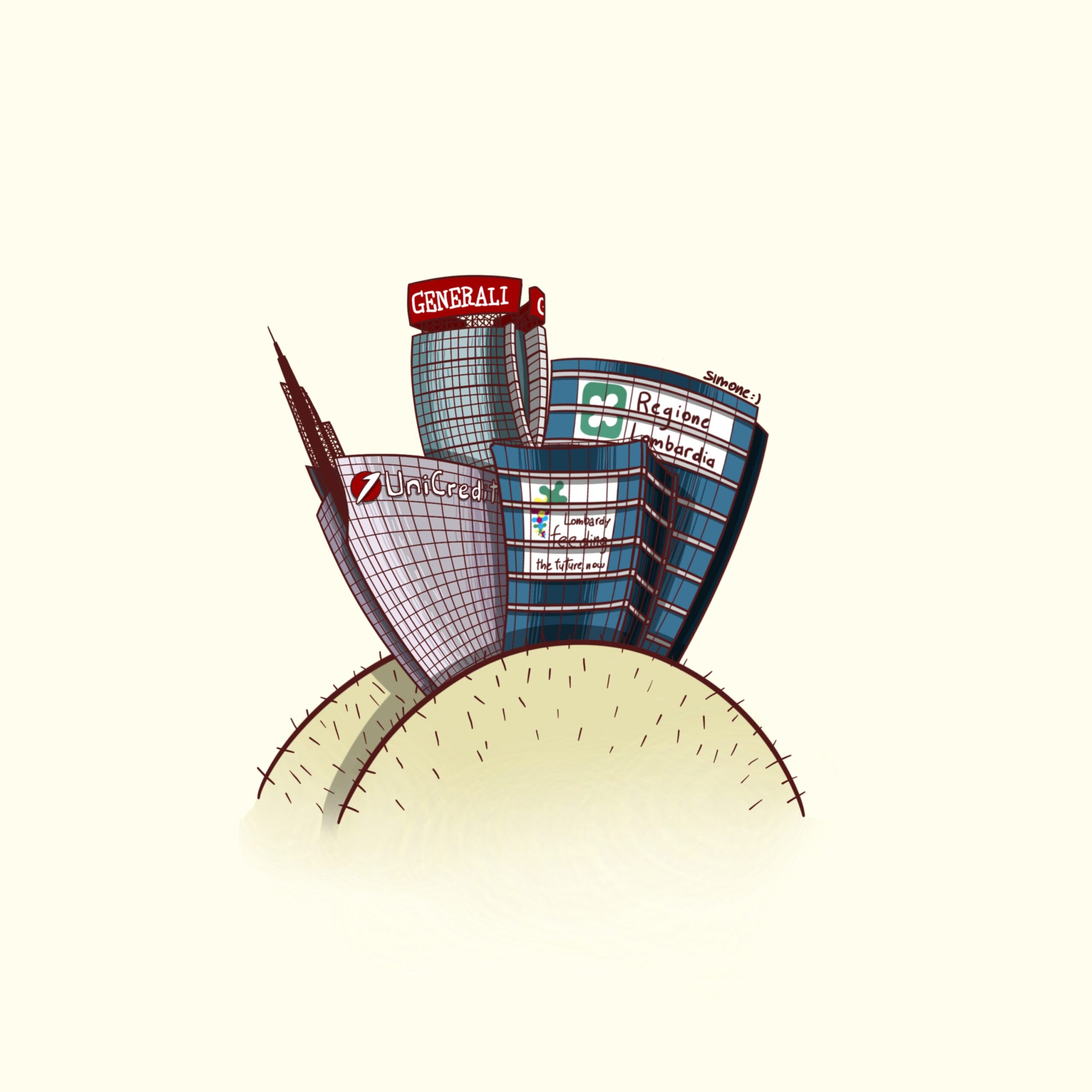Esiste un luogo dove il cuore trovi l’agognato riposo? Un luogo che possa chiamare casa e patria? Finallora errerà sperando e rammemorando, che si tratti di “un uomo, un popolo, una civiltà”. Un uomo erra in cerca di una casa, un popolo in cerca di una patria. Nel tentativo di sviluppare la questione senza separare la vicenda individuale da quella collettiva, e anzi rispettandone l’isomorfismo, prenderò in considerazione l’esperienza prima religiosa e poi storica dell’ebraismo.
L’ideologia nazionalsocialista vedeva nell’ebreo l’emblema dello “sradicato”. In un quadro nel quale la comunione fra popolo e nazione, quindi fra sangue e terra, è il valore primo e irrinunciabile, un popolo nomade ed esiliato come quello ebraico ha qualcosa di diabolico e abominevole. Il radicamento nel proprio luogo naturale è ciò che dà forza ad un popolo. Tale luogo è il Vaterland – la terra dei padri – destinato ad un popolo come sacro ed eterno possesso. L’ebreo invece, privo di una nazione, è uno sradicato; essendo nato nel deserto – questo l’ambientalismo nazista – non ha potuto affondar radici, e di qui la sua aridità spirituale. Se sfrondata da ideologismi, tale genealogia coglie un punto importante: l’ebraismo ha nella sua essenza qualcosa dell’errare. Non diversamente Dio stabilisce nel suo patto con Abramo, mitica origine del popolo ebraico: “Sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in una terra non loro; saranno fatti schiavi e saranno oppressi per quattrocento anni” (Genesi, 15). Insomma, non un accidente storico, ma un decreto divino condanna l’ebreo al deserto – declinandosi, quindi, in Babilonia, Egitto, Sinai, Spagna, America, Polonia… Non c’è luogo stabile e duraturo nel deserto, ad ogni oasi si è richiamati a ciò che si cela oltre la duna all’orizzonte.
Se ciò convince, non si deve tuttavia dimenticare che anche l’ebraismo è una religione ed una fede. Non si può quindi credere che la sua rappresentazione del cammino dell’uomo sia un puro errare senza scopo. Piuttosto, l’ebraismo, come ogni religione, si figura un luogo nel quale il deserto finisce e il cuore tormentato trova riposo. Finché non vi giunge, l’uomo ne è esiliato, tuttavia ha la rassicurante speranza che ogni sofferenza un giorno troverà la propria redenzione, e l’esilio potrà chiudere il suo cerchio nel ritorno in patria. È chiaro già qui cosa questo significhi per l’ebraismo: il ritorno alla Terra Promessa, come epilogo ideale della Diaspora. Tale evento sarebbe una “fine della storia”: un’uscita dal tormentato tempo storico verso un ideale tempo biblico ormai immutabile nelle sue conquiste, dove nulla diviene e vige un eterno presente. In realtà, a ben vedere, tale obiettivo è stato incessantemente cercato anche nella quotidianità della millenaria storia diasporica. L’ossessiva ripetizione di usi, costumi, tradizioni – il proverbiale conservatorismo ebraico, certo uno stereotipo in alcuni aspetti – ha di mira qualcosa di simile ad un’uscita dal tempo, esorcizzazione delle sofferenze storiche. Vivere l’immutabile vita del Libro è una rassicurante “patria fuori dal tempo” – e ciò valga, in contesto certamente laico, per ogni tentativo di rifugiarsi in luoghi, persone, abitudini che si vorrebbero sottratti al cambiamento. In ogni caso, per tornare al punto, la manifestazione più chiara della vocazione religiosa dell’ebraismo, nel senso in cui sopra se ne parlava, è la fede nella Terra Promessa.
Ed ecco, finalmente: ONU Risoluzione 181 del 1947, storia sacra e storia profana trovano un punto di convergenza: “l’ebreo errante è arrivato”, come titolava Londres anni prima. Non è più uno sradicato, ha anche lui il suo Vaterland. Una terra, un popolo. Possibilmente una patria nella quale le angosce passate possano venir dimenticate, certamente un confine da proteggere ad ogni costo. Questo non è però privo di problemi, almeno non lo è per una buona parte di intellettuali ebrei. La specificità del popolo ebraico era proprio quella di essere un popolo errante: “gli ebrei orientali non hanno patria in nessun luogo, ma tombe in ogni cimitero”. Tuttavia, le circostanze storiche, ovvero la nascita dei nazionalismi, hanno reso impossibile in una cert’epoca la sussistenza di un popolo senza una propria terra – e ciò non valga solo per l’orrore nazista, ma nemmeno vada limitato al solo caso ebraico. Il sionismo quindi, effetto di questo scacco, ha proposto la più naturale soluzione al problema che affrontava: il rifugio in quella Terra che da sempre è destinata al popolo ebraico. Nell’inevitabile ambivalenza che un ebreo può avere nei confronti di Israele, Joseph Roth nel 1927 ne metteva già in luce un aspetto critico: “Il sionista vuole modificare l’ebraismo dalle sue fondamenta. Vuole una nazione ebraica che si presenti più o meno come una nazione europea”. “Nazione europea” al tempo aveva un significato preciso – Vaterland – e Roth era inquietato da questo modello, lui che invece era uno strenuo ammiratore del carattere errante dell’ebreo.
Come conseguenza di tutto quanto detto finora, Primo Levi negli anni ‘70 invitava a ripercorrere a ritroso la vicenda ebraica, riguardando a valori precedenti alla creazione di Israele: esortava insomma ad un ritorno alla “cultura della Diaspora” o, come si esprime Kafka, alla “vera patria diasporica nel tempo”, piuttosto che ad una “patria nello spazio” – quest’ultima in fondo altro non è se non un tempo che si sclerotizza nel presente. Questo ci conduce a domandarci che forma abbia assunto l’esperienza storica – la “cultura della Diaspora” – del popolo ebraico e in cosa differisca da quella religiosa. Quest’ultima – in una prospettiva più ampia – venga considerata come il timore verso il mutamento e il rifugio consolatorio in un passato (o in una trascendenza) che non muta. Mentre l’altra, si vedrà, nasce proprio dal ribaltamento di quella vocazione religiosa: l’ebreo, in realtà, sa di essere condannato alla storia, ovvero all’esilio – la patria invece è un miraggio, un Heimkehr (ritorno a casa) è impossibile, come risulta dall’omonimo, e brevissimo, racconto di Kafka.
Esperienza storica dell’ebraismo, ovvero “come ognuno si sente in esilio”
Per comprendere l’esperienza storica dell’ebraismo, nella consapevolezza del suo irresolubile errare, è utile partire dalla più comune esperienza umana. Ogni uomo è consapevole di aver oltrepassato quella sottile “linea d’ombra” che conduce fuori dall’infanzia, ovvero dall’età dell’immediatezza e del “rapporto integrale fra l’anima e le cose”. Ciò che ora ne rimane è il ricordo soltanto. Si è quindi coscienti della definitiva perdita di quella inconsapevole pienezza. Una pienezza che esiste solo per colui che ne è esiliato. Solo chi è esiliato, chi non è più un infante, può avere un’infanzia. Ovvero, solo chi è inquieto, sempre trepidante, può immaginarsi un luogo che si figura stabile, in cui la vita sia piena e autentica. Si chiami tale luogo Heimat (patria, casa). Non più il sopracitato Vaterland – un possesso che facilmente si tramuta in violenza per la paura della sua perdita -, ma qualcosa che assomiglia ben più ad un sentimento di intimità. Heimat è un luogo dell’anima che mai si riduce ad un afferramento materiale una volta e per sempre. È invece una sensazione delicata, che quando emerge va sfiorata con mano accorta per non farla svanire. Per questo ha il suo modo d’essere nel racconto, nel ricordo, più che nel vissuto immediato. Ed è in questo senso si può dire che noi non possediamo la nostra infanzia.
Ci si guardi tuttavia dall’identificare Heimat e infanzia, pur essendo facile che ciò avvenga. La patria perduta, dalla quale la vita è sottratta e per questo resa incompleta, può aver luogo – oltre che nel ricordo – nel rimorso, in una possibilità, in una speranza, in una fantasia – insomma, in ciò che non appartiene alla vita non perché trascorso, ma perché altro da noi e mai vissuto. Per riassumere questi altri significati di Heimat forse basta una sola espressione, nostalgia di un posto in cui non si è mai stati. Di quest’ultima nostalgia l’esperienza storica dell’ebraismo – innanzitutto quella degli ebrei occidentalizzati, nell’ ‘800, e di quelli sopravvissuti alla Shoah, nel ‘900 – è particolarmente sofferente. Lo spaesamento che questi uomini provano per il proprio tempo trova corpo e voce nella malinconica rievocazione di idillici luoghi lontani nel tempo, o soltanto immaginati. L’inadeguatezza alla vita di Kafka, ebreo a cavallo fra Occidente e Oriente, ha le sue radici in questa lontananza da una Heimat mai vissuta. Kafka, un uomo ormai occidentale, ha “per gli ebrei orientali l’amore tragicamente impotente di chi vorrebbe essere nato fra loro e vivere la loro vita […] Sono un popolo, sono vivi, sani, indistruttibili, legati al sangue, alla lingua, alla famiglia, al costume, a quello che conta soprattutto, che conta unicamente per Kafka, e che vorrebbe e non può conseguire”. A puro titolo esplicativo si aggiunge il caso di Rilke, non un ebreo, ma comunque radicato nella stessa Praga bifronte di Kafka. Anche lui soffre di questa inappartenenza ad entrambi i mondi – a quello a cui è destinato e quello da cui si sente lontano. Il suo è “lo smarrimento di uno scrittore che sente parlare intorno a sé una lingua diversa da quella in cui scrive, un poeta di lingua tedesca che non si sente un austrotedesco e che si sente invece radicato, con la fantasia e col sentimento, nel patrimonio di altri popoli e gruppi nazionali [slavi, precisamente cechi], la cui lingua egli non conosce più o comunque troppo poco per poter diventare in essa poeta […] è costretto a dire questa sua nostalgia in tedesco, ossia nella lingua dei dominatori”.
Heimat è quindi la propria infanzia, la vita dei padri, una vita felice. In ogni caso, ciò che non si ha; perciò Heimat è, finora, simbolo di una mancanza. La percepita perdita del “mondo di ieri” ha il suo fondamento nel – o addirittura si identifica con – il timore di essere uno straniero nel mondo d’oggi. Per riprendere quindi il punto dal quale siamo partiti: a differenza dell’esperienza religiosa, in quella storico-diasporica del popolo ebraico non si spera in alcun ritorno a quel “mondo di ieri”. “Non esiste per gli ebrei orientali alcuna patria in cui poter reinserirsi come a Itaca, ma esistono solo “tombe in ogni cimitero” a cui, periodicamente ma fugacemente, ritornare per poi ripartire”. È la condizione tragica del protagonista de Il Castello di Kafka: K. si aggira per il villaggio ai piedi del colle con l’intento di giungere al Castello che vi è in cima, ma nei meandri di vie, indizi e incontri ambigui si perde come in un labirinto – e come in ogni labirinto è lui stesso l’artefice della propria perdizione. Mai riuscirà a giungere alla “piccola città che accoglie, che custodisce, che consola”. Il Castello, l’Heimat, è infine come non esistesse, frutto d’immaginazione; forse è soltanto il memento della sua condizione di esiliato. Se Kafka vedeva l’origine della sua sofferenza nel distacco dalla sua comunità, tuttavia “non avrebbe trovato pace in alcun ritorno alla tradizione, l’impossibilità del quale era solo una metafora della sua impossibilità a risolvere il proprio dramma”.
Per un’altra Heimat
Se Heimat fosse solo una mancanza, l’uomo sarebbe condannato ad essere una coscienza infelice. C’è invece anche un rovescio della medaglia, un lato positivo e produttivo è incluso nell’assoluta negatività dell’Heimat come pienezza perduta. Quel ricordo, quella fantasia, quel “puro irradiarsi di un’immagine” proviene da ciò che è più profondo in noi. È ciò che rende noi stessi quel Singolo che siamo. Heimat non è quindi solo ciò che la psicanalisi intende per la mancanza che genera il desiderio, è anche ciò che rende la nostra esperienza vivida. È l’immaginazione, la fantasmagoria che arricchisce il nostro sguardo essendone la coloritura. Così vale per Mendel Singer nel Giobbe di Roth. “In America Mendel sente che v’è una strana connessione fra il grande oceano e le paludi della Galizia, e l’acqua lo attira come la voce dell’Heimat”. Il ricordo delle paludi galiziane, non solo è simbolo di ciò che non ha più, ma è anche l’immagine fuori dal tempo che custodisce in sé l’essere più intimo di Mendel, e tale affetto sfuma di una tinta nuova ciò che lui stesso incontra nella sua vita presente e futura, l’immenso oceano americano. Heimat è quindi ciò che rende a noi affascinanti certi luoghi, persone, atmosfere… questi sono ciò che di più intimo vi è in noi – per un marinaio il mare, la sua mitologica madre. È la forza che ci attira e attrae. “Nel Leviathan il mercante di coralli avverte similmente il segreto legame fra le acque nascoste delle paludi e le acque immense degli oceani, ma tale relazione, a differenza di Mendel, lo spinge ad abbandonare la propria terra per il mare ignoto e sterminato”. Un Heimat autentica non si risolve nell’Heimweh (nostalgia, ovvero “dolore per il ritorno”), ma al contrario in un Fernweh, “dolore per l’altrove”. Il mercante di coralli sa che ciò che in lui è più intimo si trova fuori di lui chissà dove. La patria non è il Vaterland da possedere, nemmeno è il segno dell’impossibilità della quiete (Kafka), ma è una promessa di felicità da portare lungo il cammino come in una saccoccia.
Bibliografia
Claudio Magris, Lontano da dove. Joseph Roth e la tradizione ebraico-orientale, Einaudi, Torino, 1989
Franz Kafka, Il Castello, Feltrinelli, Milano, 2015
Joseph Roth, Giobbe. Romanzo di un uomo semplice, Adelphi, Milano, 1977
Joseph Roth, Ebrei erranti, Adelphi, Milano, 2016